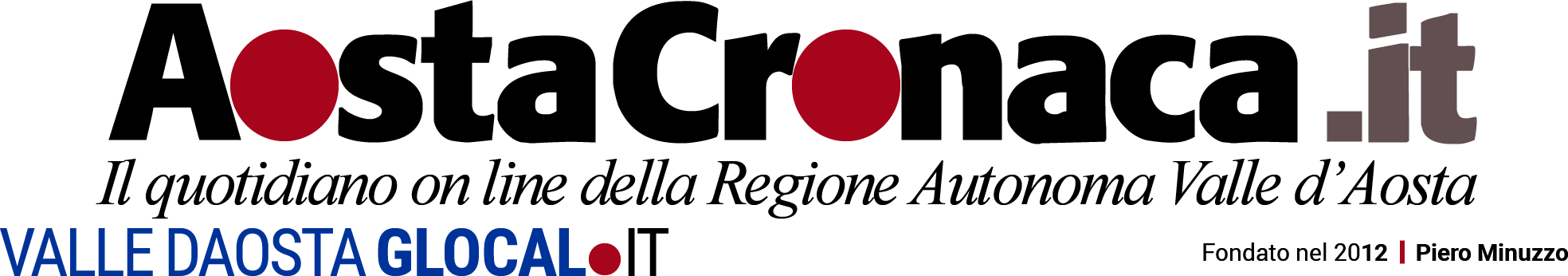Esiste in Italia una disciplina giuridica ancora non riconosciuta dalle università, ma largamente praticata nei bar, nelle chat di famiglia e nei commenti sotto i post di Facebook. Si chiama “Giurisprudenza intuitiva”. Il suo principio fondante è di disarmante semplicità: se il verdetto mi piace, è giustizia; se non mi piace, è politica. Secoli di Montesquieu, Cesare Beccaria, Hans Kelsen ridotti a un conato gastrico.
Il meccanismo è collaudato. Un imputato viene condannato: se lo odiamo, gridiamo “finalmente giustizia!” con lacrime di commozione. Se lo amiamo, la sentenza diventa immediatamente opera di toghe politicizzate, pm con ambizioni elettorali e, probabilmente, qualche oscura loggia massonica.
Se invece viene assolto, rovesciamo la frittata. I fan esultano; i detrattori parlano di sentenza comprata, sistema corrotto o, nel migliore dei casi, di “tecnicismi”, come se il garantismo fosse una malattia vergognosa da nascondere sotto il tappeto.
Fermiamoci un attimo, con la calma che la cosa merita, su come funziona davvero un processo penale. Non quello dei film americani, con avvocati brillanti che urlano “Obiezione!” ogni trenta secondi. Quello reale, quello italiano, quello noioso e meravigliosamente complesso.
Abbiamo un Pubblico Ministero, che coordina le indagini e sostiene l’accusa: è, in senso tecnico, l’avvocato della collettività, il rappresentante di quei cittadini che il reato lo hanno subìto. Poi abbiamo la polizia giudiziaria, che le indagini le esegue sul campo.
Abbiamo l’avvocato difensore, che ha il sacro compito di smontare le accuse, tutelare i diritti dell’imputato e ricordarci che ogni condanna deve essere provata, non soltanto urlata. E infine abbiamo, al centro di tutto, il giudice, che ascolta tutti, valuta le prove e, alla fine, emette una sentenza basata sul diritto.
Un sistema pensato per essere adversariale: accusa e difesa si fronteggiano e la verità processuale emerge dallo scontro dialettico, non dalla rivelazione divina. Semplice, no?
Evidentemente no. Perché noi preferiamo il metodo del tifo da stadio.
La locuzione “toga rossa” è un gioiello della retorica populista italiana. Funziona così: ogni volta che un magistrato emette una sentenza sgradita a una certa parte politica o al suo popolo di sostenitori, scatta automaticamente la diagnosi. Il giudice non ha sbagliato, non ha interpretato la legge diversamente, non ha valutato le prove in modo differente: no. È politicizzato. È di sinistra. Probabilmente ha una foto di Togliatti nello studio.
La bellezza di questa tesi è la sua impermeabilità alla realtà. Se condanna, è una toga rossa. Se assolve lo stesso imputato l’anno dopo, non viene celebrato come eroe della giustizia: sparisce semplicemente dal radar della polemica.
Il metodo scientifico prevede che una teoria, per essere valida, debba poter essere falsificata. La “toga rossa” non può. È inconfutabile come i dogmi religiosi, ma senza la poesia.
E naturalmente il fenomeno è bipartisan, anche se fatica ad ammetterlo. La stessa gente che urla di toghe rosse quando il proprio campione viene condannato batte le mani entusiasta quando la stessa magistratura indaga il campione avversario. Le toghe diventano rosse o nere a seconda di chi colpiscono, con una flessibilità cromatica davvero ammirevole. E all’occorrenza diventano persino arcobaleno.
C’è poi un piccolo dettaglio che nel dibattito pubblico viene sistematicamente dimenticato: le leggi non le scrivono i magistrati. Le leggi nascono in Parlamento. Articoli, commi, fattispecie di reato: tutto passa dall’aula parlamentare, tutto è frutto di mediazioni politiche, di compromessi tra partiti, di spinte lobbistiche, di urgenze contingenti.
I magistrati quelle leggi le applicano. Le interpretano, certo — e qui il margine esiste ed è legittimo — ma il perimetro entro cui si muovono è stato disegnato da altri. Da politici eletti da noi.
Quindi, quando una sentenza ci sembra assurda, la domanda più onesta non è “chi è questo giudice comunista?”, ma “perché il Parlamento ha scritto questa legge in questo modo?”. Una domanda molto più scomoda, perché chiama in causa noi stessi, i nostri voti, i nostri rappresentanti. Meglio dare la colpa alla toga.
Sia chiaro: la magistratura non è infallibile. I magistrati sono esseri umani, con pregiudizi, limiti cognitivi e, a volte, anche faziosità reale. Esistono sentenze sbagliate. Esistono pm che eccedono nel protagonismo. Esistono giudici che interpretano la legge in modo discutibile. La critica alla magistratura è legittima, doverosa e fa parte di qualsiasi democrazia sana.
Ma c’è una differenza abissale tra la critica fondata su argomenti giuridici e il riflesso condizionato della tifoseria. La prima è civiltà giuridica. La seconda è il contrario: è la negazione stessa del diritto, perché presuppone che la giustizia non sia una procedura fondata su norme, ma un’arena in cui dovrebbe vincere la propria squadra.
Chi oggi grida alla toga rossa perché il suo idolo è stato condannato dimentica che domani potrebbe essere lui ad avere bisogno di un giudice indipendente. E, a quel punto, vorrebbe trovarne uno che applica la legge, non uno che tifa.
La giustizia è fatta da uomini imperfetti che applicano leggi imperfette, redatte da politici imperfetti eletti da cittadini imperfetti. È un sistema umano, fragile e grandioso al tempo stesso.
Funziona, però, solo se lo rispettiamo nella sua complessità, non quando lo pieghiamo ai nostri desideri. Diversamente, non stiamo difendendo la giustizia. Stiamo soltanto cercando un esecutore per le nostre vendette.