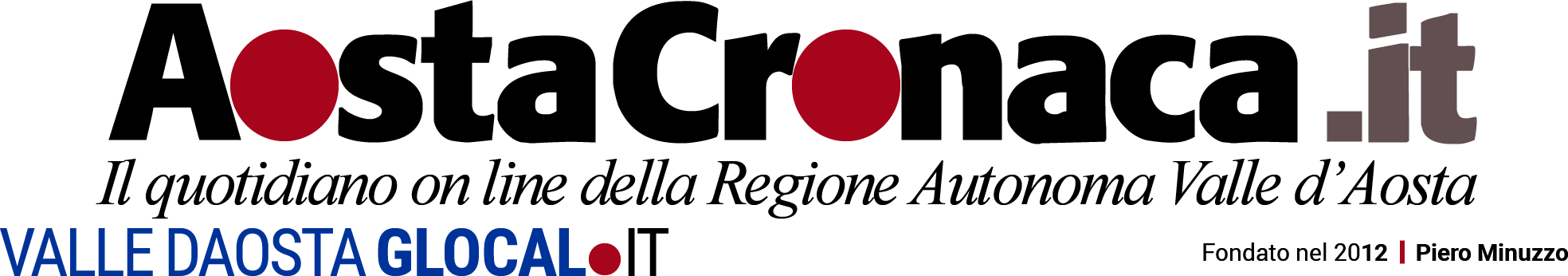In Italia sta spopolando un nuovo sport nazionale.
Non richiede preparazione atletica, non serve un campo, non c’è un arbitro. Basta uno smartphone e un po’ di frustrazione quotidiana.
Si chiama: scegli la tua tribù e odia l’altra.
Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, geniale nella sua infantilità.
Ti iscrivi a un gruppo dai toni epici — “Io sto con la Polizia”, “Il vero patriota difende la divisa” — e vieni immediatamente arruolato in una guerra civile immaginaria. Una guerra che non esiste, ma che sui social sembra più reale del mutuo da pagare.
Nel frattempo, il poliziotto che pensi di difendere è impegnato a fare i conti con la bolletta, non con la rivoluzione.
E il manifestante che insulti online probabilmente sta cercando di non perdere il lavoro, non di rovesciare lo Stato.
La costruzione del nemico perfetto — la narrazione che domina queste pagine — è sempre la stessa: da una parte i difensori della legalità, dall’altra i violenti.
Nessuna sfumatura, nessuna complessità.
Solo due curve da stadio che si insultano a vicenda.
È un trucco vecchio come la politica: prendere cittadini normalissimi e convincerli che altri cittadini normalissimi — quelli con la divisa — siano una specie di casta aliena.
Come se il vigile che ti fa la multa fosse sceso da Marte con l’unico scopo di rovinarti la giornata.
Come se il carabiniere non fosse anche lui uno che la sera guarda Netflix in mutande e impreca quando salta il Wi-Fi.
Ma sui social non esistono persone: esistono simboli.
E i simboli, si sa, sono perfetti per litigare.
La domanda che nessuno vuole fare è semplice: la proliferazione di gruppi “pro divisa” è davvero un fenomeno spontaneo?
O, almeno, sarebbe ingenuo pensarlo.
Chi li gestisce?
Chi ci guadagna?
Chi ha interesse a far credere che esista una guerra civile tra chi manifesta per il proprio lavoro e chi indossa una divisa per il proprio stipendio?
Domande legittime, che però vengono subito bollate come complottismo.
Meglio non pensarci: meglio cliccare “mi piace” su un post indignato e sentirsi parte di una crociata digitale.
Nell’era dei social non servono più comizi, adunate o manifesti.
Basta un algoritmo ben calibrato e qualche pagina creata ad arte.
Il resto lo fanno i cittadini, gratuitamente e con entusiasmo.
È un meccanismo talmente efficiente che persino Francesco Cossiga, in uno dei suoi momenti di sincerità brutale, lo aveva spiegato senza giri di parole: far credere che chi protesta sia contro lo Stato è la più antica delle strategie politiche.
E continua a funzionare.
Mentre le persone litigano online, la politica reale — quella che decide, taglia, sposta, nomina — procede indisturbata.
Chi alimenta questa macchina dell’odio non ha bisogno di iscriversi a nessun gruppo: ha già ottenuto ciò che voleva.
Il finale è già scritto.
Voi continuate pure a iscrivervi ai vostri gruppi, a condividere indignazione prêt-à-porter, a credere che ci sia davvero una guerra in corso tra voi e il vostro vicino che ha scelto di fare il carabiniere invece dell’elettricista.
Continuate a farvi dispensare odio quotidiano, confezionato con cura e servito caldo sui vostri schermi.
Chi ha inventato questo gioco non deve più fare nulla.
Ha già vinto.