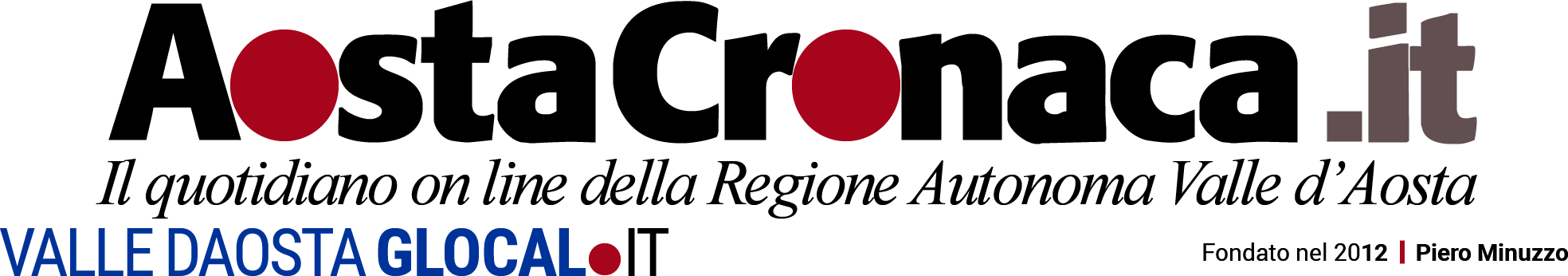Il decreto sicurezza varato dal governo non è una semplice misura amministrativa. È un segnale politico e culturale. Un segnale inquietante, che richiama da vicino l’anticamera di quella che fu la stagione più buia della democrazia italiana: il Ventennio fascista. Non per identità di contesto storico, ma per metodo, per linguaggio e per visione del rapporto tra Stato e cittadini.
Anche allora tutto iniziò così: in nome dell’ordine pubblico, della sicurezza, della necessità di “ristabilire l’autorità”. Prima la limitazione del diritto di sciopero, poi la compressione della libertà di stampa, quindi la criminalizzazione del dissenso e delle manifestazioni. Non servì un colpo di Stato: bastarono decreti, leggi speciali, emergenze costruite e l’idea che la libertà fosse un lusso sacrificabile sull’altare dell’ordine.
Il governo Meloni–Salvini sembra muoversi lungo una traiettoria pericolosamente simile. Punta tutto sulla repressione, sulla restrizione del diritto di manifestare, sulla riduzione degli spazi di opinione e di pensiero critico. Una visione che non considera il conflitto sociale come elemento fisiologico della democrazia, ma come una patologia da reprimere.
Certo, è necessario contrastare violenti e delinquenti. Nessuno lo nega. Ma confondere deliberatamente protesta e criminalità è una scorciatoia autoritaria che la storia italiana conosce bene. È esattamente ciò che accadde quando il dissenso politico venne equiparato a sovversione e l’ordine pubblico divenne uno strumento di controllo ideologico.
Una democrazia non si difende a colpi di decreti securitari. Si difende prevenendo, educando, investendo sul piano culturale ed educativo, a partire dalla scuola. Si difende rafforzando la coesione sociale, riducendo le disuguaglianze, creando cittadinanza consapevole. La sicurezza vera nasce molto prima dell’intervento repressivo.
E invece si sceglie la via opposta: quella della repressione come risposta universale, del diritto penale come strumento di governo, del sospetto come chiave di lettura del disagio sociale. Una strada già percorsa, che non portò sicurezza ma paura, non ordine ma obbedienza.
In questo contesto emerge un’altra, grave contraddizione. Gli appartenenti alla Polizia di Stato svolgono una funzione essenziale per la sicurezza, la legalità e la tenuta democratica del Paese. Sono un presidio dello Stato di diritto, non una milizia al servizio del potere. Eppure vengono sistematicamente utilizzati come scudo politico, mentre le loro condizioni reali vengono ignorate.
Da anni operano in un contesto segnato da carenze normative, strutturali ed economiche che incidono sulla dignità professionale e sull’efficienza del servizio. In molte realtà territoriali le strutture e gli alloggi di servizio sono fatiscenti. Le carriere sono bloccate, il carico di lavoro è crescente, lo straordinario è sottopagato, i salari non sono più adeguati al costo reale della vita. A questo si aggiungono organici insufficienti, turni estenuanti e una pressione politica che scarica sugli operatori responsabilità che appartengono alla politica.
È il paradosso di questa stagione: si invoca più repressione, ma non si investe davvero in chi dovrebbe garantire la sicurezza nel rispetto della Costituzione. Si chiede ordine, ma si dimentica che senza diritti, senza formazione, senza tutele, anche l’ordine si svuota e diventa arbitrio.
Il Ventennio insegnò una lezione che non dovremmo mai dimenticare: quando lo Stato smette di educare e inizia solo a punire, quando riduce le libertà in nome della sicurezza, quando trasforma il dissenso in reato, la democrazia è già in ritirata.
Questo decreto sicurezza non guarda al futuro. Guarda a un passato che credevamo definitivamente superato. E ogni volta che la repressione prende il posto della prevenzione, il problema non è solo l’ordine pubblico. Il problema è la libertà. E con essa, la democrazia stessa.
Repressione e prevenzione
Le décret sécurité adopté par le gouvernement n’est pas une simple mesure administrative. C’est un signal politique et culturel. Un signal inquiétant, qui rappelle de près l’antichambre de ce qui fut la période la plus sombre de la démocratie italienne : le Ventennio fasciste. Non pas par identité de contexte historique, mais par la méthode, le langage et la vision du rapport entre l’État et les citoyens.
À l’époque déjà, tout avait commencé ainsi : au nom de l’ordre public, de la sécurité, de la nécessité de « rétablir l’autorité ». D’abord la limitation du droit de grève, puis la compression de la liberté de la presse, ensuite la criminalisation de la contestation et des manifestations. Il n’y eut pas besoin d’un coup d’État : il suffit de décrets, de lois spéciales, d’urgences construites et de l’idée que la liberté pouvait être sacrifiée sur l’autel de l’ordre.
Le gouvernement Meloni–Salvini semble aujourd’hui s’engager dans une trajectoire dangereusement similaire. Il mise tout sur la répression, sur la restriction du droit de manifester, sur la réduction des espaces de liberté d’opinion et de pensée critique. Une vision qui ne considère pas le conflit social comme un élément physiologique de la démocratie, mais comme une pathologie à réprimer.
Certes, il est nécessaire de lutter contre les violences et la délinquance. Personne ne le nie. Mais confondre volontairement protestation et criminalité est une dérive autoritaire bien connue de l’histoire italienne. C’est exactement ce qui s’est produit lorsque la dissidence politique fut assimilée à la subversion et que l’ordre public devint un instrument de contrôle idéologique.
Une démocratie ne se défend pas à coups de décrets sécuritaires. Elle se défend par la prévention, par l’éducation, par l’investissement culturel et éducatif, à commencer par l’école. Elle se défend en renforçant la cohésion sociale, en réduisant les inégalités, en construisant une citoyenneté consciente. La véritable sécurité naît bien avant l’intervention répressive.
Et pourtant, le choix est inverse : la répression comme réponse universelle, le droit pénal comme instrument de gouvernement, la suspicion comme clé de lecture du malaise social. Une voie déjà empruntée par le passé, qui n’a pas produit plus de sécurité mais davantage de peur, non pas de l’ordre mais de l’obéissance.
Dans ce contexte émerge une autre contradiction grave. Les femmes et les hommes de la Police d’État exercent une fonction essentielle pour la sécurité, la légalité et la solidité démocratique du pays. Ils sont un pilier de l’État de droit, et non une milice au service du pouvoir. Pourtant, ils sont trop souvent utilisés comme bouclier politique, tandis que leurs conditions réelles de travail sont ignorées.
Depuis des années, ils opèrent dans un contexte marqué par de lourdes carences normatives, structurelles et économiques, qui portent atteinte à la dignité professionnelle et à l’efficacité du service rendu aux citoyens. Dans de nombreux territoires, les structures et les logements de service sont dans un état de dégradation avancée. Les carrières sont bloquées, la charge de travail augmente, les heures supplémentaires sont sous-payées et les salaires ne sont plus adaptés au coût réel de la vie. À cela s’ajoutent des effectifs insuffisants, des horaires éprouvants et une pression politique qui transfère sur les agents des responsabilités qui relèvent de la sphère politique.
C’est le paradoxe de cette période : on invoque davantage de répression, mais on n’investit pas réellement dans celles et ceux qui devraient garantir la sécurité dans le respect de la Constitution. On exige l’ordre, tout en oubliant que sans droits, sans formation et sans protections, l’ordre se vide de son sens et se transforme en arbitraire.
Le Ventennio nous a laissé une leçon que nous ne devrions jamais oublier : lorsque l’État cesse d’éduquer pour ne plus que punir, lorsqu’il réduit les libertés au nom de la sécurité, lorsqu’il transforme la dissidence en délit, la démocratie est déjà en recul.
Ce décret sécurité ne regarde pas vers l’avenir. Il regarde vers un passé que nous pensions définitivement dépassé. Et chaque fois que la répression prend la place de la prévention, le problème n’est pas seulement l’ordre public. Le problème, c’est la liberté. Et avec elle, la démocratie elle-même.