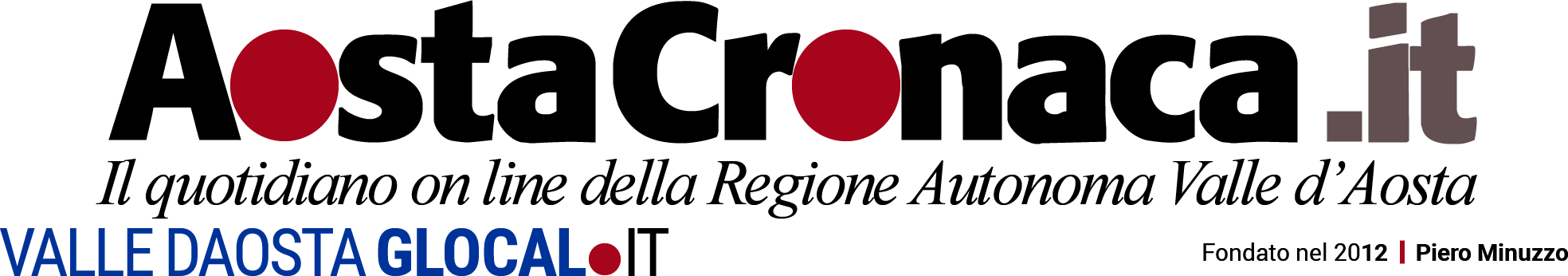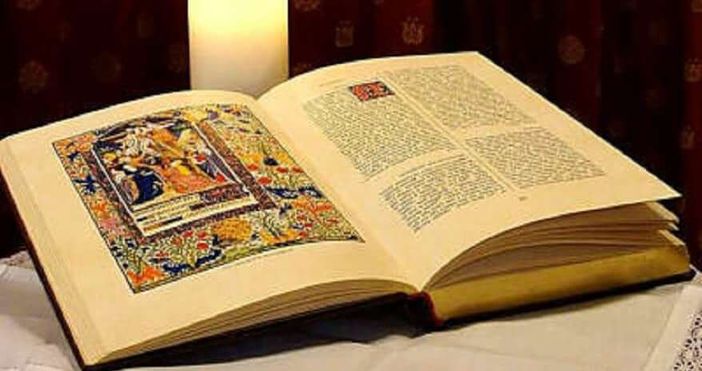La Liturgia di oggi celebra il momento in cui Gesù venne battezzato da Giovanni nelle acque del Giordano; e tra i vari elementi che ci rimangono impressi, c'è senza dubbio quella voce dal cielo che scende su di lui nel momento in cui Giovanni - inizialmente titubante - compie questo gesto: “Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. Quella voce, in realtà, richiama un altro testo biblico, quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, tratta dal profeta Isaia, il quale in realtà non parla di “Figlio” ma di “servo” di Dio. Gli studiosi della Bibbia ci dicono che nella seconda parte del libro del profeta Isaia, quella che va dal capitolo 40 al capitolo 55 della sua opera, ci sono almeno quattro canti, quattro composizioni poetiche, che descrivono la figura del “servo” di Dio, e quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura è il primo di questi quattro canti. L'ultimo, il più famoso, è quello che ascoltiamo nella prima lettura della Liturgia del Venerdì Santo, il cosiddetto “Canto del Servo Sofferente di Jahvhé”.
Questo primo canto del Servo di Jahvhè ci descrive che cosa Dio intende dire quando parla di “servo”: e dal momento che parla di lui come di uno che egli sostiene e nel quale si compiace, è abbastanza evidente la coincidenza con il “Figlio” di cui parla la voce del Giordano. Cosa significa, quindi, essere “servo di Dio”?
Il testo di Isaia ci fa comprendere innanzitutto che essere a servizio di Dio e del suo Regno non è una scelta o un'intuizione dell'uomo, e neppure dipende dalle sue buone qualità o dai propri meriti: si tratta di una libera scelta di Dio. È lui che lo sostiene, è lui che si compiace del suo servo, è lui che lo chiama per la giustizia, è lui che lo prende per mano, è lui che lo ha formato e stabilito nella sua missione. Questo serve a farci capire che l'iniziativa è sempre di Dio, e che qualsiasi annuncio di salvezza che ascoltiamo nella Bibbia è opera di Dio. Se siamo servi, siamo (come dice la parola stessa) “a servizio” di Dio, siamo strumenti nelle sue mani. Non siamo noi, quindi, i padroni della situazione, nemmeno quando ci attribuiamo la paternità di attività e di opere che riteniamo frutto delle nostre fatiche perché magari vi abbiamo investito tempo, risorse, energie.
Non possiamo, quindi, dirci autentici cristiani e testimoni del nostro Battesimo a servizio di una comunità, se ci impadroniamo delle cose che facciamo, se diventiamo gelosi per il fatto che altri possano invadere il nostro campo, quasi fosse davvero “nostro”. Se siamo servi, significa che siamo “a servizio”: il padrone è Dio, il quale, tra l'altro, pur potendo attuare da vero e proprio “padrone della situazione”, si comporta in maniera completamente opposta, ovvero con atteggiamenti di misericordia e di attenzione nei nostri confronti: per cui, non si capisce come mai noi - che rimaniamo pur sempre suoi servi - non ci dobbiamo comportare come lui.
Questi atteggiamenti di misericordia e di attenzione di Dio nei nostri confronti li vediamo indicati molto bene nel brano di Isaia, il quale dice in modo chiaro e inequivocabile qual è il comportamento che il servo è chiamato a tenere: non griderà... non spezzerà... non spegnerà... tutti verbi indicati al negativo, cioè, riportati in quel modo per negare, per impedire al servo di avere atteggiamenti da padrone. L'immagine del bastone che non deve essere spezzato e dello stoppino che non deve essere spento sono particolarmente suggestive. Isaia scrive per il popolo ebreo esiliato in terra di Babilonia, dove i re e i signori mandavano i loro araldi nelle piazze dei villaggi a proclamare in pubblico le sentenze di condanna (soprattutto le condanne capitali) agli abitanti di quei villaggi, per permettere, a chi volesse dire qualcosa a discapito degli imputati, di farlo pubblicamente. Qualora nessuno si fosse fatto avanti a difenderli, la condanna era firmata: l'araldo prendeva gli strumenti del suo viaggio (il bastone e la lanterna) e li distruggeva, spezzandoli e spegnendoli davanti all'imputato. Ecco: nelle parole del profeta Isaia viene detto in maniera chiara che questo atteggiamento di condanna, da parte del servo di Dio, non dovrà più esistere. Non ci può essere alcun uomo a cui non debba essere data, all'infinito, la possibilità di desistere dal male e cambiare vita. E questo è un diritto che va proclamato con verità, senza finzioni e senza nascondimenti.
Questo significa che l'annuncio del Vangelo non può essere imposto con forza e senza un continuo richiamo alla conversione, perché non risponde al modo con cui è stato annunciato e proclamato da Gesù, il quale - è la parte finale del testo di Isaia - è venuto per liberare: per aprire gli occhi ai ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri, e dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Essere figli nel Figlio, essere battezzati in Cristo e con Cristo, allora, significa per noi essere servi, non padroni delle nostre comunità cristiane; significa metterci a servizio degli altri in qualsiasi attività che svolgiamo, senza atteggiamenti di padronanza e di esclusività (“Questo ambito è mio perché l'ho sempre fatto io” è qualcosa che non si può sentire in una comunità cristiana...); significa essere uomini e donne di misericordia, non esecutori implacabili e spietati di sentenze di condanna; significa annunciare un Vangelo che libera, non che opprime; significa - come fece Giovanni - sapersi mettere da parte, di fronte al Maestro. E tutto questo, proprio in virtù del nostro Battesimo, di quella “compiacenza” di Dio, che mediante il Battesimo ci ha chiamati a essere suoi Figli.
Non rinneghiamo, quindi, il nostro Battesimo con l'annuncio di un Vangelo che invece di donare libertà e vita, uccide le speranze degli uomini e li rende schiavi delle nostre pretese di onnipotenza.