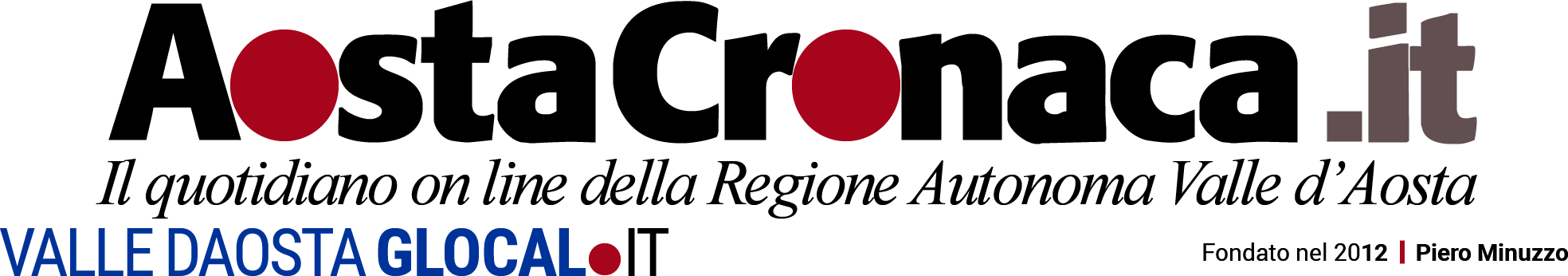Porte spalancate, perché tanto non c'è più nulla da rubare.
E proprio guardando quelle porte, in questi giorni di dicembre, quando il freddo morde e le luci di Natale cercano di scaldare i cuori, mi è tornato in mente un vecchio detto: quando si chiude la porta di un nonno, con lui scompare un'epoca. Non avevo mai capito fino in fondo quanto fosse vero, fino a ora.
Quei paesi fantasma nelle foto di Sergio raccontano una storia che va oltre le mura scrostate e i tetti crollati. Raccontano di generazioni intere che se ne sono andate, portandosi dietro non solo le loro vite, ma interi universi di saperi, tradizioni, modi di essere. I nostri nonni vivevano barricati in quei villaggetti sepolti dalla neve tre mesi all'anno, con un campo di patate, un piccolo orto, qualche mucca. E chi aveva il maiale faceva festa tutto l'anno.
Una ricchezza che oggi non sapremmo nemmeno riconoscere.
Ma eccoci qui, in questo Natale moderno, con le nostre case riscaldate e i nostri supermercati aperti anche la domenica, a urlare. A cercare colpevoli per un vuoto che non sappiamo più spiegare.
E contro chi urliamo? Non contro chi ha permesso questo decadimento, no. Urliamo contro il povero immigrato, quello che una volta era "il terrone", "il calabrot", come dicevano i nostri vecchi, con quella diffidenza che allora sembrava naturale.
Quasi con sospetto antropologico, si celebrarono i primi matrimoni tra valdostani e calabresi o veneti, in quei tempi in cui la gente osservava la bella calabrese come si guarda un fenomeno atmosferico imprevisto. “Avrà mica circuito il povero valdostano?”, sussurravano. E soprattutto: “Non sarà che punta a diventare la padrona di quella stalla con ben otto mucche?”.
No, non è una barzelletta né un esercizio di sarcasmo facile: era proprio la verità nuda e cruda di quei tempi, quando l’amore doveva ancora ottenere il permesso di soggiorno.
Eppure, proprio con quei terroni, con quei calabresi, abbiamo costruito un pezzo di storia. Quando sono cadute quelle barriere di razzismo, quando abbiamo imparato a vedere oltre la paura del diverso, insieme abbiamo costruito case, strade, un futuro. Oggi in Valle d'Aosta sono proprio loro, quei "diversi" di ieri, ad aiutarci a tenere in piedi la nostra regione.
Questo avrebbe dovuto insegnarci qualcosa di prezioso: che diverso non significa peggio. Che con il diverso puoi convivere, costruire, crescere. Ho visto nascere famiglie meravigliose dall'incontro tra valdostani e ragazze arabe, brasiliane, indiane; famiglie che portano in sé la promessa di un mondo più ricco, più vasto.
Se solo ci ricordassimo, in questo periodo di Natale, quando si parla tanto di accoglienza, che i nostri nonni insieme ai "diversi italiani" – così li chiamava mio nonno – hanno costruito questo paese. Se solo riuscissimo ad amare un po' di più l'umanità e a vedere meno differenze intorno a noi, forse potremmo tornare a costruire un paese ricco e prospero come quello che loro ci hanno lasciato.
Ma finché continueremo a lasciare voce a chi predica chiusura e diffidenza, saremo destinati a vedere chiudere altri usci. Come quelli dei villaggi nelle foto di Sergio: spalancati sul vuoto, in attesa di nessuno.
E quando l'ultima porta si chiuderà, quando l'ultimo nonno se ne sarà andato portandosi dietro la sua epoca, cosa resterà di noi? Che storia racconteremo ai nostri nipoti? Quella di un paese che ha avuto paura di aprire le porte, proprio mentre quelle dei suoi avi si spalancavano abbandonate al vento della montagna?
Questo Natale, forse, potremmo provare a ricordare. A tenere aperte le porte, non per dimenticanza, ma per scelta. Per accoglienza. Per costruire ancora, insieme, come facevano i nostri nonni quando la neve copriva tutto e bastava un maiale per fare festa tutto l'anno.
Perché alla fine, quello che ci hanno insegnato non era solo come sopravvivere all'inverno. Era come restare umani.